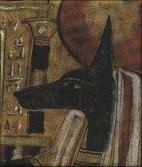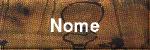

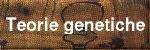
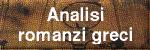

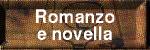


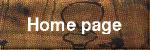
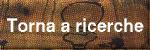
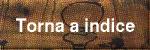
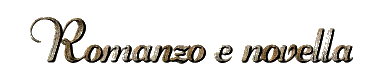
Il nome novella non è da considerarsi una traslitterazione né un calco dal Greco. I Greci infatti non hanno un nome specifico e unico per definirla, ma la designano con gli stessi termini con i quali vengono indicati altri generi letterari ad essa affini, senza che sussista un'immediata distinzione (μῦθος, λόγος, ἀπόλογος, διήγημα, διήγησις). Alla novella, effettivamente, per molto tempo non viene riconosciuta una propria autonomia come genere. È altrettanto improbabile che la parola derivi dal Latino classico, in quanto il racconto breve è designato con i termini: fabula, fabella, narratio, res ficta ed exemplum fictum. La denominazione è invece del tardo Latino e del volgare (novus, novellus,a,um: il femminile dell'aggettivo indica novità, racconto agile) e trova la sua attestazione nella narrativa in lingua volgare fin dalla sua fase primigenia (Il novellino). Il percorso evolutivo della novella greca antica consta di due periodi in un certo senso distinti, anche se non sempre cronologicamente separabili.
Il primo momento è paleoionico: la Ionia, che vide fiorire la poesia epica e la storiografia dei logografi, era terreno naturale per il sorgere della novellistica, per compiere quel processo di avvicinamento "del dato divino o meraviglioso all'esperienza razionale e alle proporzioni umane, che è la condizione spirituale che spiega il sorgere della novella". In tale periodo, definito dal critico M. Pelayo novella prima della novella, questa si confonde con la tradizione mitologica, il racconto epico e la narrazione storica o pseudo-storica, assumendo pertanto il carattere serio, tragico, romanzesco.Ecco una serie di esempi tratti da importanti testi della letteratura greca:
- Iliade: il giudizio di Paride (I libro), storia di Melagro (IX libro), Διὸς Ἀπάτη (XIV libro).
- Odissea: tela di Penelope, Ares e Afrodite nella rete di Efesto (VIII libro), ἀπόλογοι di Circe, Lotofagi, Polifemo, Eolo, Vacche del Sole, Scilla e Cariddi (IX-XII libro), αἰνὸς del mantello di Odisseo da Eumeo. Tipo dello sciocco buono a nulla: il Margite.
- Le novelle erodotee di Solone e Creso, di Atys e Adrasto, di Policrate, di Gige e Candaule hanno carattere di digressione spesso separata dallo sviluppo degli eventi; così quella di Cambise, della figlia di Cleope o le novelle drammatiche di Periandro e del re Etearco.
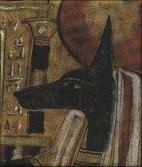
Nel secondo momento, neoionico, essa prende coscienza di sè e trova la sua forma peculiare in organismi autonomi e propri, di carattere realistico, scherzoso;
- Esopo: novella della vedova (fab. 109 Halm.), novella dell'amante dai capelli biondi (fab. 56 Halm), il corpus delle fabule περὶ ἀλόγων ζῴων
- le cosidette novelle sibaritiche, περὶ ἀνθρώπων (come recita lo scolio ad Aristofane, Uccelli, 471), aneddoti comici, umoristici, erotici, che avevano come bersaglio gli abitanti di Sibari, sciocchi ed effemminati (forse originari della rivale Crotone?), di cui c'è eco in Aristofane, Uccelli 671 sgg. e Vespe 1427, e che ricorda Ovidio, Tristia, 18 e Callimaco, Αἴιτια, elegia di Aconzio e Cidippe;
- Senofonte: novella di Pentea e Abrodata (Ciropedia 5,1);
- Ovidio: Aconzio e Cidippe (Heroides), Piramo e Tisbe (Metamorfosi);
- Aristide di Mileto: Milesiaca;
- Plutarco: la novella di Timoclea (Conone, 50);
- Luciano: De dea Sira (19.26), dialoghi delle cortigiane;
ma anche frasi ed espressioni proverbiali, allusioni, residui di novelle popolari rintracciabili ad esempio in Plutarco o come la celebre, e per altro oscura, battuta di Prassinoa a Gorgo in Teocrito, Id. XV, 77: ἔνδοι πᾶσαι, ὁ τὰν νυὸν εἶπ᾽ ἀποκλᾴξας sono tutte dentro, disse dopo aver chiuso fuori la sposa; gli Ἐρωτικὰ Παθήματα di Partenio di Nicea, o le perdute fabulae milesiae. L'indagine sugli aspetti propri della novella diviene fondamentale all'interno delle numerose teorizzazioni sulla genesi del romanzo, benché uno dei più autorevoli esponenti della critica ottocentesca, il Rohde, neghi la possibilità di tale linea interpretativa. Egli, infatti, sostiene che i due generi, romanzo/novella, siano completamente scissi, proprio in quanto accentua del romanzo il carattere idealizzato, come l'unico specifico e distintivo, opponendovi l'aspetto realistico della novella. Ma l'interpretazione di Rohde sembra ormai superata dalla critica contemporanea, grazie, in particolare, all'innovativo contributo di Cataudella. Questi suppone, infatti, che siano esistite novelle più serie, tragiche e probabilmente anche idealizzate appartenenti alla fase paleoionica, i cui caratteri, peraltro, sono rintracciabili nella tradizione letteraria e poetica successiva: i casi di Piramo e Tisbe nelle Metamorfosi di Ovidio, Orfeo ed Euridice nelle Georgiche di Virgilio e l'ampia novella aretalogica di Amore e Psiche nelle Metamorfosi di Apuleio. Anche per il romanzo, del resto, non è da escludere una linea di sviluppo realistica, il cui caso più emblematico e noto è il Satyricon di Petronio; tale linea non sarebbe sopravvissuta all'opera censoria bizantina e medievale, a causa della sua eccessiva licenziosità e volgarità. Per cui il Cataudella ipotizza che alcuni romanzi greci si siano formati sullo schema della novella che ne avrebbe costituito in qualche caso il nucleo originario. Ad avallare tale ipotesi vi sono le due versioni del romanzo idealizzato di Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte: una è più ampia, l'altra pervenuta attraverso un ritrovamento papiraceo, presenta una redazione breve. Cataudella giunge a sostenere, quasi provocatoriamente, che se il papiro che attesta la redazione breve si potesse datare precedentemente all'altra più ampia, allora si potrebbe affermare che la novella, in questo caso come probabilmente in altri, abbia dato origine all'intreccio più ampio e organico del romanzo.
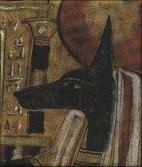
LA FABULA MILESIA
Il termine romanzo, nell’ambito della narrativa d’amore e d’avventura in lingua greca e latina fiorita nel periodo ellenistico e greco-romano, è improprio, dal momento che si riferisce a canoni di narrazioni in termini moderni. Nella retorica greca esso è definito διήγημα o μῦθος, in quella latina fabula o fabella. Tuttavia il fatto che non ne esista una descrizione è segno che la fabula non era considerata un genere autonomo con regole proprie. Il romanzo più antico di cui abbiamo testimonianza, il romanzo di Nino, risale al I secolo a.C. Tuttavia sappiamo che fin dal II secolo a.C. circolavano in Grecia racconti di carattere spregiudicato e licenzioso definiti generalmente Μιλησιακά. La fabula milesia nasce appunto nel II secolo a.C. in Grecia; si tratta di brevi racconti realistici e divertenti a sfondo erotico e avventuroso. Massimo esponente del genere è Aristide di Mileto (da cui Μιλησιακά), che legò il suo nome alle fabulae perché ne fece una raccolta nel II secolo a.C., mentre prima esse circolavano per lo più in forma orale. I racconti sono modellati su una struttura a cornice in cui il narratore espone i fatti in prima persona. Probabilmente l'ambientazione era Mileto, ma forse essa serviva solo come sfondo al racconto-cornice. Dalla Ionia arrivarono poi a Roma attraverso la traduzione in latino di Lucio Sisenna, storico e oratore del I secolo a.C., e qui ebbero un’ampia diffusione e un notevole successo. Ne siamo certi poiché Plutarco, nella Vita di Crasso, racconta che, durante la battaglia contro i Parti a Carre (53 a.C.), la truppa nelle pause della battaglia, si distraeva con la lettura delle fabulae milesiae tradotte da Lucio Sisenna. Altra testimonianza di questa grande diffusione ci è fornita da Ovidio. Ovidio, nei Tristia, per protestare espressamente contro le motivazioni del suo esilio, al quale sarebbe stato condannato probabilmente a causa dell’eccessiva licenziosità dell’Ars Amatoria, afferma che sia Aristide sia Sisenna avevano legato il proprio nome ad un genere più sfrontato del suo, eppure non erano stati esiliati:(Trist., II, 413-414)iunxit Aristides milesia crimina secum
pulsus Aristides nec tamen urbe sua estvertit Aristiden Sisenna nec obfuit illi historiae turpes inseruisse iocos (Trist., II, 443-444)
La prima citazione chiarisce un punto importante della tecnica utilizzata dagli scrittori di fabulae milesiae, ovvero la narrazione in prima persona con impostazione autobiografica. E’ interessante rilevare come Ovidio definisca milesia crimina e turpes iocos le favole in questione con termini simili a quelli utilizzati da Plutarco, Crassus, XXXII, ἀκόλαστα βιβλία, vale a dire "libri sfrenati, licenziosi". Alla tradizione milesia risale anche una tecnica ad incastro in cui un personaggio narra una novella all’interno della vicenda. Questo artificio di fondere diverse novelle è qualificato appunto da Apuleio come sermo milesius: At ego tibi sermone isto milesio varias fabulas conseram. Le fabulae milesiae trattavano casi erotici e magici, con interessi per gli eventi soprannaturali e metamorfici. L’aspetto magico della fabula milesia in Apuleio sembra confermare l’attenzione e il gusto per il macabro e l’orrido testimoniati in età neroniana anche dalle tragedie senecane e dal Bellum Civile di Lucano. La produzione favolistica latina si può rintracciare anche in altri autori. In primo luogo Fedro, che nel corso della sua attività letteraria si allontana sempre di più dalle favole esopiche di carattere moralistico, evidenziando nelle sue novelle non tanto il carattere erotico ma quello umoristico. Riscontriamo caratteri ascrivibili alla fabula milesia anche in Valerio Massimo, nei suoi Factorum Memorabilium Libri, in Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, ma soprattutto in Gellio, vissuto nel II secolo d.C., nelle cui Noctes Atticae, tra aneddoti, ricordi, brevi trattati grammaticali e linguistici, compaiono admiranda, cioè "casi mirabili, degni di essere narrati". La novità dello schema di tale produzione favolistica è testimoniata anche dal fatto che sarà utilizzato nella letteratura agiografica medievale come modello per l’exemplum edificante.